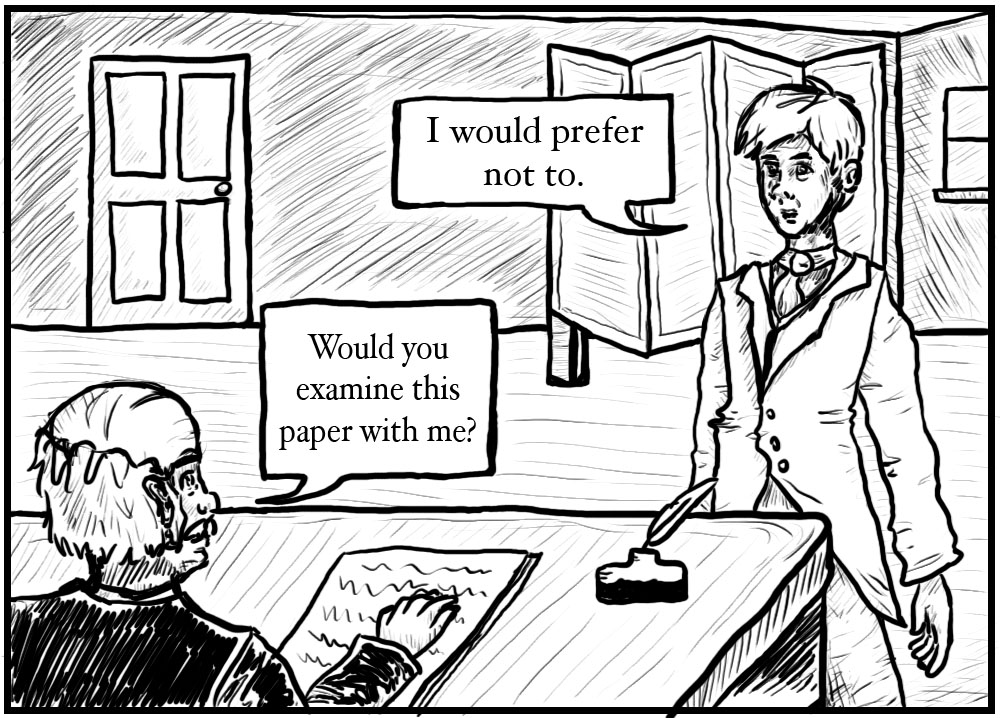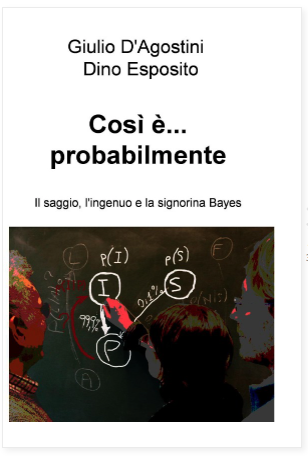Con questo primo articolo inauguriamo il percorso legato al Sistema Scuola, un filone per fornire una nuova panoramica su un argomento che, generalmente, si dà per scontato.
Ognuno di noi ha dovuto frequentare almeno la scuola dell’obbligo e i più fortunati, ammettiamolo, hanno anche potuto proseguire gli studi nei livelli di istruzione superiori e universitari, riuscendo così a percorrere le strade che più gli si addicevano.
Il “Sistema Scuola” è fatto di tanti e diversi elementi, istituzionali e umani. A partire dagli allievi, fino ai livelli amministrativi, il nostro intento è quello di dare voce a ognuno di loro, creando un quadro che rappresenti tutti i pezzi di questo fantastico mosaico per dimostrare che, solo se tutte le tessere sono in armonia tra loro, la scuola potrà essere, oggi come in futuro, un vero e proprio sistema aperto alle contaminazioni e al cambiamento.
Cosa diamo per scontato?
 Il termine scuola deriva dal latino schola che, a sua volta, deriva dal greco scholè. Questa parola identificava il tempo concesso allo studio, al ragionamento e agli insegnamenti che venivano impartiti nelle ore in cui era permesso riposare dalle quotidiane attività lavorative.
Il termine scuola deriva dal latino schola che, a sua volta, deriva dal greco scholè. Questa parola identificava il tempo concesso allo studio, al ragionamento e agli insegnamenti che venivano impartiti nelle ore in cui era permesso riposare dalle quotidiane attività lavorative.
Con il passare del tempo, l’evoluzione della Storia ha permesso di identificare con i medesimi termini i luoghi fisici in cui i docenti e gli allievi si incontrano e dove gli uni insegnano agli altri quanto di conosciuto e ritenuto necessario in base ai diversi periodi storici.
L’accezione moderna di scuola è riconducibile all’opera di Carlo Magno il quale, con la Schola Palatina di Aquisgrana, delineò un primo nucleo di scuola pubblica, immaginando nell’educazione intellettuale, morale e religiosa dei popoli barbari che componevano il suo regno un elemento di unità.
A dirla tutta, però, nelle fonti storiche sono riportate esperienze scolastiche già dai tempi degli egizi e successivamente in tutte le società organizzate.
Ovviamente non bisogna pensare al “sistema scolastico” di allora e che ha attraversato la storia con la mente di oggi, come bisogna considerare che nei tempi passati gli “alunni” erano solo i destinati a posizioni amministrative o di governo.
Perciò, con l’evolversi del tempo e lo sviluppo delle varie civiltà che si sono susseguite nel tempo, è stata costruita l’idea di scuola che andava da sistemi di istruzione per le elité, molto basici e tecnici, alle organizzazioni articolate e organizzate dei giorni nostri, aperte a tutti.
Insomma, il sistema scuola è giustamente mutato nella storia e, ringraziando il caso o chi per esso, se siamo nati in questi due ultimi secoli e nella parte fortunata del mondo, abbiamo potuto studiare, migliorare noi stessi e diventare quel che siamo.
I giovani e la scuola di oggi
 Siamo nel 2017 e, nessuno lo può mettere in dubbio, oggi la scuola è cambiata.
Siamo nel 2017 e, nessuno lo può mettere in dubbio, oggi la scuola è cambiata.
Pubblica, paritaria o privata, ciò che conta è la possibilità che viene data ai nostri figli di frequentare ambienti fatti di professionisti in grado di insegnare loro quello che è successo nel tempo, le basi della nostra cultura moderna, fino ai calcoli matematici più impensabili. I veri protagonisti del mondo della scuola sono prima di tutto loro, i ragazzi che dai sei anni, mese in più mese in meno, entrano in questo mondo per vivere un periodo di crescita e sviluppo che li porta alla terza media e all’esame di maturità. I più volenterosi e fortunati, proseguono gli studi e frequentano con successo le università, riuscendo in molti casi ad eccellere anche nel futuro mondo professionale.
Ma i bambini e i ragazzi come vivono e come vedono la scuola?
Parafrasando la regola delle 5 W del giornalismo, abbiamo fatto una indagine molto semplice e intervistato cinque di loro per sapere cosa ne pensano.
I cinque intervistati, che rimarranno anonimi per ragioni di riservatezza, rappresentano uno spaccato equilibrato per quanto riguarda la provenienza, l’età e il sesso, iscritti regolarmente dalla scuola elementare all’università.
Le domande sono state molto semplici e dirette:
1. Cosa significa per te la scuola?
2. Cosa cambieresti e perché?
3. Come vivi la scuola?
4. Cosa ti ha insegnato?
5. Cosa ti piace della scuola?
Le risposte sono riportate in base all’ordine scolastico ed è indicata genericamente la scuola frequentata e un nome di fantasia.
Adele frequenta la scuola elementare.
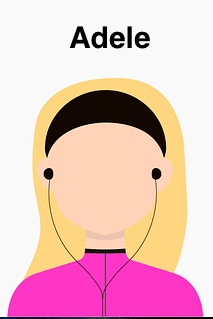 Crede che la scuola sia un luogo per in contrarsi e per imparare, anche se ha già capito che è proprio in quell’ambiente che si iniziano ad avere i primi scontri con la realtà. Le piace fare i compiti ma preferirebbe svolgerli a scuola il pomeriggio con i compagni e le insegnanti, piuttosto che a casa, dovendo rinunciare ad altre attività pomeridiane. Il suo ambiente scolastico è variegato e lo vive in serenità, riuscendo ad intrattenere rapporti ed amicizie praticamente con tutti. Proprio tra i banchi di scuola ha imparato a gestire i rapporti con gli altri, oltre che ad apprendere ogni giorno molte delle cose che oggi sa di sapere, dall’educazione alle materie.
Crede che la scuola sia un luogo per in contrarsi e per imparare, anche se ha già capito che è proprio in quell’ambiente che si iniziano ad avere i primi scontri con la realtà. Le piace fare i compiti ma preferirebbe svolgerli a scuola il pomeriggio con i compagni e le insegnanti, piuttosto che a casa, dovendo rinunciare ad altre attività pomeridiane. Il suo ambiente scolastico è variegato e lo vive in serenità, riuscendo ad intrattenere rapporti ed amicizie praticamente con tutti. Proprio tra i banchi di scuola ha imparato a gestire i rapporti con gli altri, oltre che ad apprendere ogni giorno molte delle cose che oggi sa di sapere, dall’educazione alle materie.
Bruno frequenta la scuola media.
 Ritiene la scuola un luogo dove si va per imparare prima di tutto ma anche dove fare nuove amicizie e divertirsi con gli amici. Se potesse cambierebbe il rapporto tra gli insegnanti e gli alunni, credendo che la troppa formalità limiti la voglia di ascoltare. Vive la scuola in maniera seria, fa i compiti, segue le lezioni con interesse, ma come può preferisce decisamente interagire con gli altri compagni e divertirsi con gli amici ai quali è molto legato. Grazie alla scuola ha imparato a relazionarsi con gli altri e sono stati proprio gli altri a fargli tornare la voglia di andare a scuola quando qualcosa non andava.
Ritiene la scuola un luogo dove si va per imparare prima di tutto ma anche dove fare nuove amicizie e divertirsi con gli amici. Se potesse cambierebbe il rapporto tra gli insegnanti e gli alunni, credendo che la troppa formalità limiti la voglia di ascoltare. Vive la scuola in maniera seria, fa i compiti, segue le lezioni con interesse, ma come può preferisce decisamente interagire con gli altri compagni e divertirsi con gli amici ai quali è molto legato. Grazie alla scuola ha imparato a relazionarsi con gli altri e sono stati proprio gli altri a fargli tornare la voglia di andare a scuola quando qualcosa non andava.
Caterina frequenta il bienno della scuola superiore.
 Per lei la scuola è una fonte di istruzione, un luogo dove si impara a studiare, si apprendono argomenti, ma soprattutto è un luogo dove ci si confronta con gli altri. È un posto che forma culturalmente e moralmente. Preferirebbe intensificare le attività pratiche, dato che rispetto ad altre scuole nel mondo siamo molto legati alla teoria più che alla pratica, vorrebbe fare più ore di laboratorio e dare più spazio alla storia dell’arte che ritiene importante per il nostro paese. Le farebbe piacere che la scuola valorizzasse maggiormente ciò che le sta attorno. I ragazzi dovrebbero essere maggiormente considerati dalle “autorità” come il dirigente scolastico e dagli insegnanti perchè le cose vadano meglio. Vive la scuola con impegno ed è costante nel rendimento scolastico, mantenendo uno spirito adatto per imparare e per convivere con il gruppo classe e con i professori. Ha imparato molte cose e molte altre ne imparerà, perchè la scuola fornisce degli insegnamenti legati alla cultura ma anche alla morale. Della scuola le piace la pluralità di indirizzi di studio adatti a tutti, lasciando così la libertà di essere ciò che si vuole diventare.
Per lei la scuola è una fonte di istruzione, un luogo dove si impara a studiare, si apprendono argomenti, ma soprattutto è un luogo dove ci si confronta con gli altri. È un posto che forma culturalmente e moralmente. Preferirebbe intensificare le attività pratiche, dato che rispetto ad altre scuole nel mondo siamo molto legati alla teoria più che alla pratica, vorrebbe fare più ore di laboratorio e dare più spazio alla storia dell’arte che ritiene importante per il nostro paese. Le farebbe piacere che la scuola valorizzasse maggiormente ciò che le sta attorno. I ragazzi dovrebbero essere maggiormente considerati dalle “autorità” come il dirigente scolastico e dagli insegnanti perchè le cose vadano meglio. Vive la scuola con impegno ed è costante nel rendimento scolastico, mantenendo uno spirito adatto per imparare e per convivere con il gruppo classe e con i professori. Ha imparato molte cose e molte altre ne imparerà, perchè la scuola fornisce degli insegnamenti legati alla cultura ma anche alla morale. Della scuola le piace la pluralità di indirizzi di studio adatti a tutti, lasciando così la libertà di essere ciò che si vuole diventare.
Daniele frequenta il trienno della scuola superiore.
 La scuola per lui significa Istruzione. Dopo la famiglia pensa sia l’istituzione che dovrebbe guidare i giovani nelle proprie scelte di vita e del futuro. Vede la scuola come un luogo per ritrovare i compagni e condividere con loro opinioni diverse. Cambierebbe il modo di fare le lezioni, vorrebbe un mondo scolastico pronto a coinvolgere i ragazzi e non renderli semplici auditori. Riferisce che l’alternanza scuola-lavoro non è più lo specchio di ciò che si studia nelle ore scolastiche, restando quasi dei binari paralleli. Vive la scuola molto serenamente, la percepisce come un ambiente piacevole anche e soprattutto perchè ha potuto scegliere in libertà un indirizzo scolastico molto vicino alle sue passioni, nonostante senta avvicinarsi l’ansia per gli esami di maturità. E’ consapevole che dalla scuola ha imparato principalmente che le proprie idee, giuste o sbagliate che siano, vanno condivise e discusse insieme, apprezzando il duro impegno che viene svolto dai professori per indirizzare i giovani verso le loro scelte.
La scuola per lui significa Istruzione. Dopo la famiglia pensa sia l’istituzione che dovrebbe guidare i giovani nelle proprie scelte di vita e del futuro. Vede la scuola come un luogo per ritrovare i compagni e condividere con loro opinioni diverse. Cambierebbe il modo di fare le lezioni, vorrebbe un mondo scolastico pronto a coinvolgere i ragazzi e non renderli semplici auditori. Riferisce che l’alternanza scuola-lavoro non è più lo specchio di ciò che si studia nelle ore scolastiche, restando quasi dei binari paralleli. Vive la scuola molto serenamente, la percepisce come un ambiente piacevole anche e soprattutto perchè ha potuto scegliere in libertà un indirizzo scolastico molto vicino alle sue passioni, nonostante senta avvicinarsi l’ansia per gli esami di maturità. E’ consapevole che dalla scuola ha imparato principalmente che le proprie idee, giuste o sbagliate che siano, vanno condivise e discusse insieme, apprezzando il duro impegno che viene svolto dai professori per indirizzare i giovani verso le loro scelte.
Elena frequenta l’università.
 Prima di tutto si ritiene una persona fortunata perchè non tutti hanno la sua stessa possibilità di frequentare l’università, vista come una grande opportunità di crescita e formazione personale. Soffre il fatto che i professori incontrati nel suo percorso universitario, in alcuni casi, non abbiano dato lo stesso peso agli insegnamenti stessi e alle prove in itinere che sono programmate. Riconosce nell’università un percorso di studio sicuramente difficile che crea in lei l’ansia di fronteggiare le varie prove, laddove alcuni docenti non considerano gli sforzi degli studenti. Sicuramente per lei l’università è un luogo dove nulla è dovuto ed è consapevole che per raggiungere tutti i traguardi del percorso bisogna impegnarsi. Apprezza l’ambiente studentesco e il dialogo aperto con i professori, quando questi sono disposti a concederlo, senza nascondersi dietro troppi formalismi.
Prima di tutto si ritiene una persona fortunata perchè non tutti hanno la sua stessa possibilità di frequentare l’università, vista come una grande opportunità di crescita e formazione personale. Soffre il fatto che i professori incontrati nel suo percorso universitario, in alcuni casi, non abbiano dato lo stesso peso agli insegnamenti stessi e alle prove in itinere che sono programmate. Riconosce nell’università un percorso di studio sicuramente difficile che crea in lei l’ansia di fronteggiare le varie prove, laddove alcuni docenti non considerano gli sforzi degli studenti. Sicuramente per lei l’università è un luogo dove nulla è dovuto ed è consapevole che per raggiungere tutti i traguardi del percorso bisogna impegnarsi. Apprezza l’ambiente studentesco e il dialogo aperto con i professori, quando questi sono disposti a concederlo, senza nascondersi dietro troppi formalismi.
Adele, Bruno, Caterina, Daniele ed Elena esistono realmente, come realmente vivono il mondo scolastico, unendolo con le proprie esperienze di vita, le città in cui abitano, le passioni che gli attraversano le vene.
Sono ragazzi che hanno ben chiaro cosa significa la scuola e il viverla in tutti i suoi aspetti.
Sono ragazzi fortunati, liberi di poter pensare, di poter svolgere i loro compiti, certi che un giorno metteranno a frutto quanto imparato, cosa questa non scontata.

Ringraziamo questi ragazzi e le famiglie per averci concesso il privilegio di chiacchierare con loro e di averci mostrato un volto nuovo del Sistema Scuola. Il volto del futuro.
Francesca Tesoro

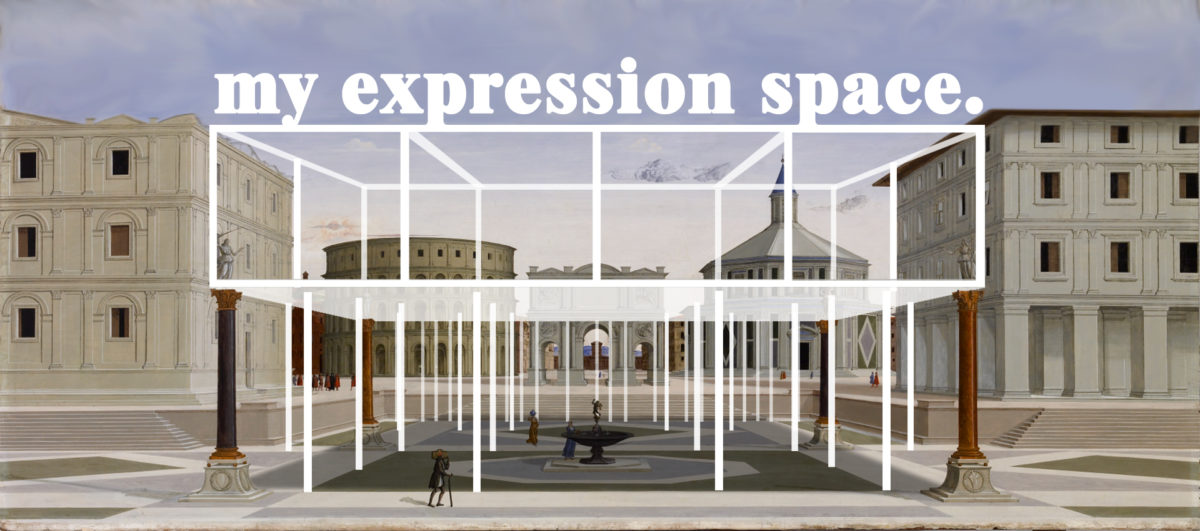





 Tutto quanto riportato in questo libro è una traduzione magistrale di momenti ed immagini dinamiche e materiali, che hanno reso quel momento di condivisione un momento di vita e non un semplice evento scolastico.
Tutto quanto riportato in questo libro è una traduzione magistrale di momenti ed immagini dinamiche e materiali, che hanno reso quel momento di condivisione un momento di vita e non un semplice evento scolastico.