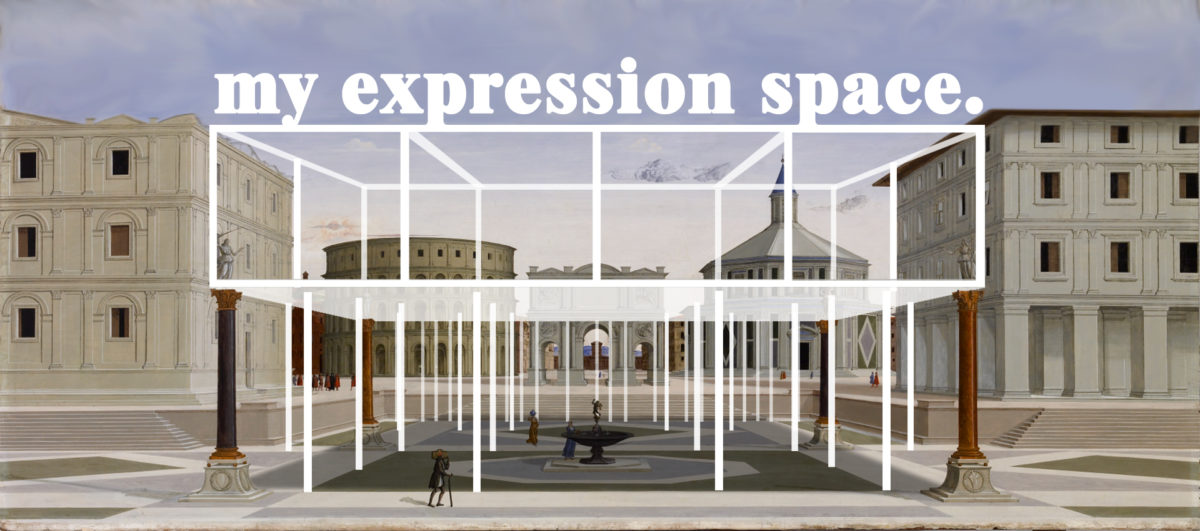La scelta di frequentare o completare l’Università all’estero è una tendenza in rapida e recente crescita in Italia: dati del MIUR rivelano come nel 2015 il 3,1% degli studenti italiani abbia intrapreso un percorso universitario oltre confine, a fronte di un 2,9% dell’anno precedente. Nel 2006 la percentuale era dell’1,5%. Secondo la società di consulenza Omni Admissions, il 42% degli studenti che partono hanno scelto il Regno Unito, il 26% gli USA, il 32% un Paese europeo. All’interno di questi dati, diversi sono i profili, l’età e le motivazioni.
Il mio progetto di conseguire un Master nel Regno Unito è giunto in una fase particolare, forse insolita, della mia vita. Non ero una diciottenne fresca di banchi di scuola, piuttosto lontani i ricordi delle versioni di greco e latino, gli struggimenti adolescenziali, quel fecondo caos emotivo e intellettuale che giocava a creare immagini del mio futuro come ombre cinesi.

Avevo, invece, qualche anno in più speso tra autoconsapevolezza e disillusione. Dopo una laurea triennale in Scienze Politiche e una Specialistica in Relazioni Internazionali alla LUISS, il mio bagaglio di amore per gli studi sociali e internazionalistici, di conoscenze e di incertezza uscivano tutti rafforzati. Cosa ero brava a fare, con cosa mi ero misurata, fuorché digerire stoicamente manuali e sfoggiare analisi di politica internazionale?
Mi sono districata nella giungla degli uffici di supporto alla ricerca di lavoro dell’Università, delle candidature di lavoro, CV e lettere motivazionali per qualche anno, collezionando tre, quattro stage e un breve contratto di consulenza nel settore della Cooperazione Internazionale. Dovunque ho lavorato, la percezione che non ci fosse alcun interesse nel farmi restare oltre il presente contratto. È iniziato un periodo di confusione, progressiva chiusura in me stessa. Congiuntura economica, circostanze socio-culturali del mio paese, seri problemi familiari che mi hanno investito in quegli anni, o semplicemente io che non ero nel posto (settore) giusto? La confusione cresceva, alimentata dal cambiare e cambiare lavoro, che rendeva difficile (impossibile) consolidare competenze e capire cosa volessi, potessi, dare.
Dovevo specializzarmi. L’illuminazione, e la voglia di mettermi in gioco arrivarono nelle lunghe pause di un lavoro meccanico e routinario (facevo nientemeno che i controlli di sicurezza in aeroporto in quel periodo). Sarei ripartita da ciò che ho sempre amato fare: scrivere. La curiosità di varcare i confini, della mia mente, del Paese, di ciò che conoscevo, un partner con la cittadinanza americana. Misi insieme i pezzi di questo puzzle un po’ delirante e feci domanda per il Master in Giornalismo Internazionale della School of Oriental and African Studies (SOAS) di Londra.

Appena trasferita, mi resi conto dell’unicità di quella scuola, di quanto rappresentasse allo stesso tempo Londra e una finestra speciale sul mondo. Con il mio inglese ancora un po’ incerto, mi trovai immersa in una girandola di visi, colori, accenti, sorrisi. Tutto era nuovo, le ragazze velate in aula, dietro le scrivanie degli uffici amministrativi e in biblioteca. A tanto non avevo mai dato un volto prima. Paesi, culture la cui immagine era unicamente tracciata nella mia testa dalle pennellate monodimensionali e sensazionalistiche dei mass media avevano ora volti e mille storie diverse da raccontare.
La scuola era una potente cassa di risonanza delle ‘storie meno raccontate’: dibattiti, conferenze, proiezioni e concerti, cogestiti da studenti e professori, confluivano tutti nell’obiettivo di scardinare una visione eurocentrica del mondo, di offrirne una più pluralistica, non deformata dai media occidentali; per rifarsi a un gergo molto amato in SOAS, di ‘decolonizzare’ il nostro modo di guardare la realtà.
Ricordo l’approccio didattico, traumatico per me. Piccoli gruppi di studenti sparsi intorno a molti banchi vuoti. Il professore seduto sulla cattedra, cosi vicino, che chiede cosa pensiamo delle letture assegnate per quel giorno. Chiede non le teorie, né se è tutto chiaro. Chiede un dialogo, un contraddittorio sui testi di Barthes, di Gramsci. Ricordo quanto mi sentissi impreparata a esprimere il mio parere a un docente su un piano di parità. Lo stupore e il turbamento di sentire la mente totalmente vuota. L’inibizione, l’insicurezza. La difficoltà linguistica. Il fare incoraggiante e gentile dei professori, le loro risposte pressoché istantanee alle nostre email.
Ricordo Elisa, la prof. più amata del mio corso, con cui avevo l’invidiato privilegio di poter parlare a tu per tu in lingua madre. Il suo sguardo gentile, il suo ciuffo di capelli blu. Svolgeva ricerca sull’utilizzo delle tecnologie digitali presso comunità rurali in Cina. Il suo corso, ‘Global Digital Cultures’, ha affrontato una serie di tematiche etiche e culturali legate all’era di Internet e delle moderne tecnologie della comunicazione. Ricordo il suo interesse per le nostre storie, il nostro bagaglio personale di idee e credenze, la sua curiosità e apertura, che contrastavano in modo affascinante con la sua timidezza.

Ricordo quanto, ai miei occhi di ex-studentessa italiana, sembrasse uno (splendido) film di fantascienza il fatto che la SOAS avesse un intero Dipartimento dedicato al benessere psicologico dello studente. In Regno Unito la salute mentale giovanile e’ una piaga sociale. Ma anche nella mia esperienza e in quelli di molti amici, la vita universitaria si carica spesso di difficoltà e disagio. Nella Scuola di Studi Orientali e Africani di Londra, in piu’, problemi di integrazione in un paese straniero e nel suo sistema didattico, solitudine e alienazione sono tutt’altro che insoliti per gli studenti.
I motivi sono tanti e ci sono tutti, dunque, eppure a me sembrava fantascienza. Personalmente, ho seguito degli incontri pomeridiani di meditazione, e un singolare workshop di due ore sulla ‘procrastination’ (non potevo credere che qualcuno avesse pensato a un workshop per chi ‘soffrisse’ della tendenza a rimandare gli impegni accademici). Mentre ero in Italia per le vacanze di Natale, sono stata investita da un lutto familiare. In quell’occasione, mandai un’email agli uffici competenti per sapere se era possibile posporre le scadenze di alcuni lavori scritti. L’email di risposta, oltre ad accogliere la mia richiesta, mi informava in modo discreto dei servizi che il Dipartimento di supporto psicologico offriva in circostanze come le mie.
L’esperienza è stata assolutamente unica sotto il profilo umano e intellettuale, e radicalmente diversa da quella italiana. Mi ha offerto prospettive totalmente nuove sulla realtà, e rivelato la conoscenza non come un prodotto finito da esibire, ma come dialogo. Ho toccato con mano un sistema in cui il dubbio, la difficoltà e la crisi sono considerate parti naturale del processo di formazione e come tali sono prese in carico, al fine di non lasciare nessuno indietro.

Lungi da me disprezzare l’Università del mio Paese, perché è stato grazie a essa e all’intero sistema scolastico italiano che ho affrontato il Master preparata e sicura di alcuni fondamentali strumenti, in particolare della capacità di analizzare e interpretare il mondo. Alla prova dei fatti, durante il Master ho elaborato saggi e un progetto di tesi che univano le mie idee alla capacità di argomentare in modo analitico e coerente, e che per questo sono stati accolti con entusiasmo.
Eppure, non potrò dimenticare lo shock, e la sensazione di inadeguatezza durante molte lezioni, quando, spinta ad offrire idee e spunti personali sulle teorie studiate, ho sentito la mia mente come una tabula rasa. Non solo io. Molti sembravano affetti dalla stessa sindrome (tra di essi, molti studenti orientali, mentre più disinvolti in assoluto apparivano, senza sorpresa, gli statunitensi). Resta un mistero quanto di questo fosse dovuto a timidezza, quanto alla lingua. A me ha fatto pensare a quanto tempo ed energia abbia speso, durante il mio percorso di studi in Italia, nell’imparare a comprendere e riportare teorie e nozioni, e a quante volte sia stata invece spinta, stimolata a darne la mia visione. Quante volte la modalità di valutazione, dalle elementari all’Università, sia stata incentrata sulla verifica della mera comprensione e apprendimento, piuttosto che sulla discussione critica. Nella mia esperienza, il confronto è, purtroppo, impietoso.
Non voglio neppure santificare la mia esperienza qui in Regno Unito. Insospettabilmente, la scuola si è dimostrata farraginosa in più di un’occasione sotto il profilo organizzativo e burocratico. Non tutti i docenti del mio corso, pur affabili e privi della quella tipica autoreferenzialità di casa nostra, si sono dimostrati professionalmente validi. Al momento attuale sono in attesa dei miei ultimi risultati e la SOAS deve ancora passare lo spinoso esame del supporto nella ricerca di lavoro, al cui solo pensiero, ancora una volta, tremo.

Alcune delle cose che porterò con me di questo anno sono una gioiosa e chiassosa fioritura di nuovi e diversi interessi, vissuti attraverso i legami di amicizia con persone distanti per nazionalità e cultura; la curiosità di mettere in discussione le letture più tradizionali della realtà e di chiedermi, quando ascolto una storia che avviene a migliaia di chilometri da me, se ci sono altri modi di raccontarla.
Forse più di tutto, una prospettiva sulla conoscenza più intimamente connessa con l’apertura e la ricerca, che con il contenuto, meravigliosamente (e ironicamente) riassunta in una frase che Elisa, la professoressa italiana, ci disse a fine corso: “A questo punto della vostra carriera di studi, quello che vi auguro non è di avere le giuste risposte, quanto di farvi le giuste domande.”
Chiara Marandino